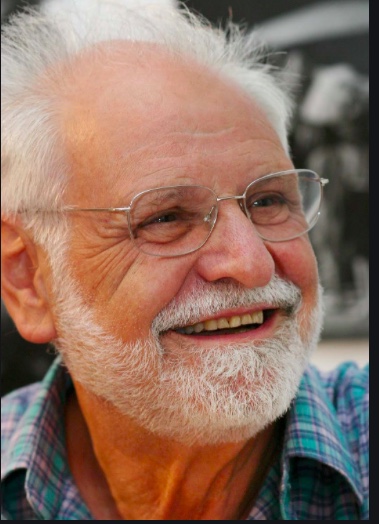
Una pedagogia della resistenza. Recensione a “L’oppio del popolo” di Goffredo Fofi
di Marco Gatto
«E se la cultura, in tutte le sue forme non radicali, che non guardano all’origine dei mali e non ne cercano il rimedio, non fosse altro, oggi, che lo strumento privilegiato del dominio, lo strumento di cui il potere si serve per asservirci, per farci accettare l’inaccettabile?». È questa la domanda che Goffredo Fofi si pone sulla soglia de L’oppio del popolo, un volume edito da Elèuthera che raccoglie scritti di occasione e riflessioni sull’oggi firmati dal critico eugubino. Non si tratta di una provocazione. Tale potrebbe apparire, abituati come siamo a paradossi senza sostanza, se non si assumesse il punto di vista dell’autore, che certo paradossale non è. Fofi raccoglie in eredità una posizione, chiamiamola pure così, “anticulturale”, che la migliore sociologia, la migliore teoria della cultura, la migliore critica sociale del secolo scorso, attualmente in fase di sopravvivenza, ha consegnato al lettore odierno, e che tuttavia può risalire fino a quei modelli di interrogazione politica di matrice moderna che hanno visto nell’elaborazione culturale e nell’attività intellettuale il centro di una possibile risposta filosofica e politica di stampo radicale alle contraddizioni materiali dell’era capitalistica. Da Gramsci fino alla teoria critica, passando per Günther Anders e Christopher Lasch (modelli dichiarati), uno sguardo critico erede di questa traiettoria non può che arrendersi a un’evidenza, che Fofi pone al centro delle sue riflessioni: da strumento di emancipazione e di conoscenza concreta della realtà, da arnese per la trasformazione collettiva, la cultura, non solo nella sua declinazione consumistico-spettacolare, appare oggi, nell’epoca della pervasività simbolica e della comunicazione digitale, una sorta di seconda epidermide, di seconda natura, che ovviamente si presenta del tutto aderente allo svuotamento generalizzato della capacità critica, della lucidità politica, della possibile costruzione di un’identità collettiva non servile. Finito il moderno, la cultura, ci suggerisce Fofi, si è ridotta a un enorme contenitore estetizzato, animato da una logica totalitaria (pari a quella del suo “gestore” primario, il capitale), nel quale persino gli sguardi critici meno intimiditi – e ce ne sono, tiene a rimarcare l’autore – sono neutralizzati, perché trascinati su un terreno che, giocoforza, li addomestica. E dal momento che lo spazio culturale sposa le ragioni del consumo, cui aderisce per sopravvivere, la sua risposta alle sollecitazioni del reale finisce per essere comunque affermativa, rincuorante, tranquillizzante, anche quando vorrebbe veicolare propositi di negazione, di allarme, di non-accettazione (per usare un’espressione di Capitini, uno dei maestri di Fofi).
Si dirà: è l’ennesima geremiade degli intellettuali contro l’industria culturale. Non lo è per due ragioni. La prima: le pagine più significative del libro sono quelle che, dati statistici alla mano, dimostrano come l’industria della cultura (di chi scrive, filma, recita, danza, fa riviste, organizza fiere e consessi) rappresenti al giorno d’oggi una fetta importante della produzione di ricchezza. Deve pertanto entrare in competizione con altre merci. Ha dei destinatari, dei consumatori. Ancora per poco, probabilmente, ma esiste, per dirla col sarcasmo di Fofi, «una massa di persone che non sanno che fare del loro tempo libero (della loro vita) e frequentano i festival per sentirsi anche loro intelligenti e al passo coi tempi (e cioè con le più recenti tra le proposte del mercato)»; esiste cioè un contenitore antropologico che si nutre di prodotti culturali opportunamente confezionati, il cui consumo è vissuto certamente come fattore distintivo e di classe, ma la cui pervasività non si limita all’approvvigionamento dell’una o dell’altra merce, dell’una o dell’altra occasione ludica, bensì alla costituzione profonda dei modi di pensare, dei modi di essere, di relazionarsi col mondo. È questa inversione valoriale che Fofi vuole probabilmente mettere al centro: l’uomo che si forma e educa nel mondo culturale odierno costituisce una soggettività acritica, debole, servile, “drogata” da contenuti che non provengono più da un’elaborazione profonda, lucida, seria delle questioni vere e centrali, ma da una rinuncia organizzata al senso, la quale, tuttavia, si presenta nelle forme persuasive della libertà e della democrazia dei consumi. Ne viene fuori un disorientamento amministrato, nel solco del quale si fa fatica a riconoscere le eccezioni. La seconda ragione è più personale e riguarda l’autore di questo aureo libretto. Fofi è un reduce. Ha conosciuto la civiltà contadina e la modernizzazione che, figlia di una falso progresso, l’ha distrutta. Ha frequentato Danilo Dolci, del quale è stato, appena diciottenne, collaboratore a Palermo; ha seguito la lezione dei Levi, degli Scotellaro, dei Rossi-Doria. Si è reso protagonista dei movimenti – sempre con lo sguardo dell’outsider – e ha osservato lo sfacelo del Paese dalla specola delle riviste, delle quali è stato il principale animatore dal Dopoguerra a oggi. Rappresenta, a giusto merito, uno dei pochi testimoni di un lavoro culturale – fatto non solo di scrittura, ma anche e soprattutto di organizzazione materiale – che è stato, per sua stessa vocazione, minoritario, e però teso alla trasformazione permanente della realtà, alla sua non-accettazione, al rifiuto di qualsivoglia conformismo, al ripudio della viltà e del potere. Fofi, insomma, è un intellettuale militante: una figura del moderno, oggi costretta a confrontarsi amaramente con una società che al lavoro culturale assegna tutt’altro compito e che rifiuta in modo sistematico – relegandoli al margine o, peggio, neutralizzandoli in forme accettabili – il dissenso e il conflitto. Non può essere dunque lamento o querimonia la parola di chi si produce, a volte tentato dal nichilismo – perché riconosce con realismo la sostanziale inutilità delle sue parole, che sembrano messaggi in una bottiglia lasciati alle sorti della tempesta –, in una resistenza non passiva, alla quale Fofi ha dato, in altri suoi scritti, un nome ben preciso, seguito dai fatti: disobbedienza civile.
In un libro di qualche anno fa, due sociologi francesi, Gilles Lipovetsky e Jean Serroy, parlavano di cultura-mondo[1]. Per raffigurare la società contemporanea in Occidente utilizzavano un’immagine precisa: la cultura è l’involucro che avvolge gli individui del tardo capitalismo, che indirizza le loro vite verso il galleggiamento in uno spazio estetico indifferenziato. L’immaginazione sociologica di un Lasch e una manciata di avvertiti filosofi lo ha ribadito più volte: servo volontario di un sistema che gli promette libertà incondizionata, l’Io del nostro tempo è chiamato a far cultura di se stesso, a costituirsi come prodotto tra gli altri, a vendersi, a presentarsi, rivelarsi, esporsi. Sarebbe riduttivo parlare, con tono francofortese, di stupidità generalizzata. È una questione sistemica, che si lega al percorso sempre più alienante che la “forma di vita” occidentale ha intrapreso. Il depotenziamento del conflitto, della negazione, della non-accettazione passa attraverso un suo inglobamento in quelli che chiamerei, stimolato dalle riflessioni di Fofi, “mercati del risentimento”. Più in generale, la cultura è l’articolazione propulsiva della prigione capitalistica, nella quale siamo tutti, chi più chi meno felicemente, rinchiusi. Espulso, sanzionato, è allora un pensiero del “fuori” che sappia, in un certo senso, rompere l’involucro del culturale, e che istituisca la necessità di nuove pratiche. È il “che fare?” che l’intellettuale eredita da una modernità che ancora sopravvive. Fofi ne riconosce le forme: non si esime dal considerare alcune espressioni artistiche, come il teatro e certo cinema, che ancora riescono ad aprire nuove possibilità, anche nel contesto italiano. Individua in alcuni movimenti di contestazione qualche barbaglio di civiltà. Ma, a parere di chi scrive, il suo ragionamento risulta più incisivo quando indica il terreno sul quale un principio conflittuale deve continuare ad aver senso: la scuola. È sulla scuola – sull’idea di pedagogia sociale che dovrebbe animarla: non una pedagogia dei numeri, delle “abilità” e delle “competenze”, ma una pedagogia nuovamente e davvero umanistica, che ponga al centro il travaglio della crescita, le sue contraddizioni – che si gioca, particolarmente nel nostro Paese, la scommessa del futuro. Scrive Fofi: «Il paradosso post-moderno della scuola è che essa, che ieri strappava i più ad altre esperienze, non sempre meno valide, permette oggi ai più esperienze certamente povere ma sostituiscono, per quanto male, un immenso vuoto di esperienze». Di questa minima resistenza possibile, di questa pur esigua dote, occorre approfittare, prima che la scuola pubblica – la scuola di un sapere condiviso che dia a tutti possibilità di esprimere il proprio disegno, riconoscendosi in un Noi – venga totalmente smantellata o, ancora peggio, resa servile al dominio e alla manipolazione delle coscienze. Per dire che una contro-cultura, ovvero la restituzione del nesso cultura-emancipazione, deve porsi urgentemente, ma con strumenti consapevoli e verificati, il problema della ricostruzione, del ricominciare, quando tutto è o pare perduto, da capo.
[1] Gilles Lipovetsky e Jean Serroy, La cultura-mondo. Risposta a una società disorientata [2008], Milano, O barra O, 2010.