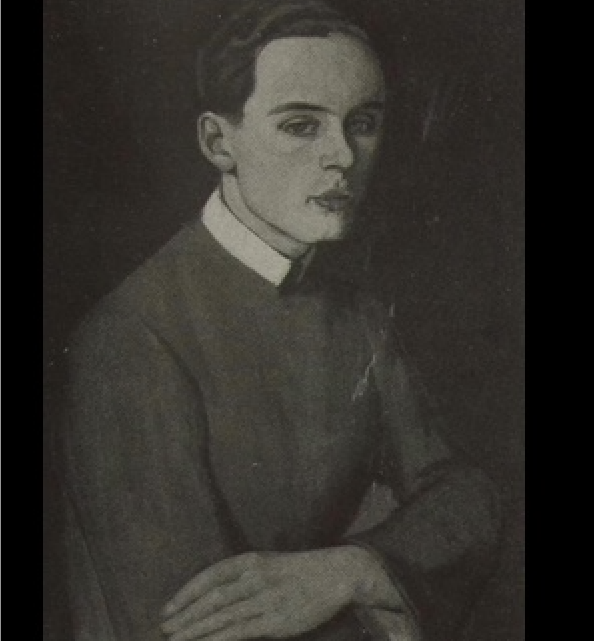
Due ritorni: Didier Eribon e Sergio Bologna – di Luca Lenzini
1.
Retour à Reims di Didier Eribon uscì in Francia nel 2009 per Fayard, in Italia è apparso solo nel 2017 (tradotto da Annalisa Romani) per i tipi di Bompiani[1], quando oltralpe era da tempo un best seller per la saggistica: 65000 copie vendute in sei anni – per un saggio si stima un successo raggiungere le 1500 – e vanno aggiunti, a conferma della larga circolazione, il film e la versione teatrale che ne sono stati tratti[2]. Colpisce perciò il ritardo della traduzione del “saggio autobiografico” di Eribon (autore della biografia più accreditata di Foucault[3]), specie quando si rammenti che fino agli anni Ottanta anche le più effimere novità editoriali francesi trovavano un riscontro quasi immediato nel nostro paese; ma a ben vedere, perché stupirsi? Dice qualcosa, anche questo, sulla nostra industria culturale, appiattita sulle mode e orientata sui generi di più facile smercio, e che predilige, soprattutto, i prodotti delle vedettes mediatiche, sia pure d’accatto. Chi passi in rassegna le note di Ritorno a Reims, del resto, si accorge ben presto che tranne per i titoli dei vari Sartre, Merleau-Ponty, Bourdieu e Foucault, i numerosi riferimenti bibliografici delle note del libro sono in gran parte a testi non tradotti in italiano; e non è il solo segnale di arretratezza o superficiale miopia, perché perfino nella confezione del “paratesto” dell’edizione italiana del libro si coglie il tentativo – piuttosto goffo, veramente – di orientare il lettore verso una fruizione di ordine narrativo-romanzesco, genericamente sganciata dal concretissimo orizzonte sociologico, insieme politico e polemico, dell’opera: «Il racconto di un ritorno che, come tutti i ritorni, non ha né può mai avere fine», recita lo strillo di copertina, depistaggio mitizzante e generico nonché fuor di luogo.[4]
Eppure, uno dei pregi più evidenti di Ritorno a Reims, in quanto sopralluogo sul background (geografico e sociale) dell’autore, è quello di saper ibridare e intrecciare strettamente il motivo autobiografico e narrativo con la riflessione critica e autocritica, esercitando e mettendo alla prova i ferri del mestiere: lo sguardo in soggettiva è impiegato da Eribon come strumento d’analisi (non di rievocazione o sublimazione elegiaca), per cui ogni passaggio del racconto è calato nella discussione sul presente, sul come e perché la società, lungo gli anni, ha preso una certa direzione e non un’altra – come avviene, per esempio, che una famiglia proletaria che un tempo aveva come indiscusso riferimento il Partito Comunista voti ad un certo punto per Le Pen. E la famiglia, prima di tutto, è il luogo esemplare e per così dire il laboratorio del dialogo, anche teorico, di Eribon con il proprio tempo, con la propria classe di appartenenza, ovvero con quelli che egli chiama i «destini sociali[5]», ciò che è al centro del libro. Dialogo, in questo senso, è anche e innanzitutto conflitto, scontro con le idées reçues e i pregiudizi, confronto tra generazioni, tra centro e periferia, e aperta battaglia di interpretazioni divergenti sull’oggi; né diversamente avviene con il motivo dell’omosessualità, che se assume centralità e pregnanza nel libro è in quanto direttamente collegato al tema dell’emancipazione e, con esso, a quello della rimozione (e della violenza): fattori che concorrono nell’investire il vissuto e la stessa identità del soggetto in una dialettica conoscitiva, prospettica. È guardando in sé stesso che, verso la fine del libro, l’autore riconosce retrospettivamente di essere stato segnato in profondità «da due verdetti sociali: un verdetto di classe e un verdetto sessuale[6]». Vista a sua volta come elemento dinamico, reattivo e non statico, in Eribon l’identità non è alcunché di rigido bensì fluida, contraddittoria: colta in via di cambiamento, come nei “romanzi di formazione”, non per questo prelude ad una riconciliazione.
Il rinvio alla dimensione teorica di ambito sociologico non è quindi per niente astratto in Ritorno a Reims, così come affatto elegiaca è la cornice del ritorno. «Il lavoro di sé su di sé[7]» e l’indagine sull’ambiente, di cui i familiari sono i primi interpreti, vanno di pari passo senza riferirsi ad assiomi deterministici, spiegazioni che convalidano precetti elaborati in chiave “scolastica” o visioni che mascherano appena interessi di parte. C’è anzi nel libro un deciso e lucido orientamento a interpretare i fenomeni sociali in una ottica “dal basso”, ed è proprio su questa base che Eribon può trovarsi in disaccordo, per esempio, con Gilles Deleuze, il quale quando afferma essere i problemi del Terzo Mondo «più vicini a noi di quelli del nostro quartiere» dimentica che
Negli ambienti popolari, nella “classe operaia”, la politica di sinistra consisteva prima di tutto in un rifiuto molto pragmatico di ciò che si subiva nella propria vita quotidiana. Si trattava di una protesta, e non di un progetto politico ispirato da una prospettiva globale. Si guardava intorno a sé, non in lontananza, sia nello spazio che nel tempo. E anche se si ripeteva spesso: “Ci vorrebbe una bella rivoluzione”, questa frase fatta era più legata alla difficoltà delle condizioni di vita e al carattere intollerabile delle ingiustizie, che alla prospettiva d’instaurare un sistema politico diverso[8].
L’aggettivo «intollerabile» non è, nella pagina di Eribon, un termine come un altro, una formula abusata. Va visto invece come il segno in cui coagula un sentimento dominante, che come tale informa il fondamento stesso del libro, la sua ragion d’essere. L’io parla, in effetti, in quanto è mosso dalla volontà di rispondere alla violenza sociale, che è tanto quella esercitata dal padre in famiglia quanto quella propria delle istituzioni (la scuola, l’università in primo luogo) e dei comportamenti collettivi, conformisti o condizionati e condizionanti che siano. Di qui le parentele dichiarate del testo con quelli di James Baldwin[9] e Raymond Williams[10] (ma non meno presenti, sullo sfondo, Nizan, Sartre, Bourdieu, Fanon per i loro scritti autobiografici); di qui, anche, i passi di più forte e incisivo impatto sui piani paralleli della rappresentazione e della riflessione, come nell’incontro con la madre vecchia e inferma:
Quando la vedo oggi, il corpo bloccato dai dolori legati alla durezza del lavoro eseguito in piedi per quindici anni in piedi davanti a una catena di montaggio (bisognava attaccare coperchi a contenitori di vetro, con la possibilità di farsi sostituire dieci minuti la mattina e dieci minuti il pomeriggio per andare in bagno), sono impressionato da cosa significhi concretamente, fisicamente, l’ineguaglianza sociale. Perfino questa parola “ineguaglianza” mi appare come un eufemismo che derealizza la questione di fondo: la violenza nuda dello sfruttamento. Il corpo di un operaio, quando invecchia, mostra a ogni sguardo cos’è la verità dell’esistenza delle classi[11].
I corpi come testi leggibili dei destini sociali; la violenza come filo rosso sotteso al governo della società, ovvero delle vite; l’esclusione come decreto in esse iscritto. La demistificazione degli «eufemismi» che svelano l’ottica del potere ed il momento autobiografico del Ritorno sono coerenti con la natura polemica – dunque politica, ancora – di cui si fa latore il libro. E in tale intreccio di motivi e momenti è la sua forza, doppiando lo spessore del vissuto quello della riflessione, in un reciproco arricchimento.
Di seguito al passo ora citato Eribon si chiede poi
perché e in che modo le condizioni di lavoro disumane e gli slogan per denunciarle – “Abbasso i ritmi infernali!” – siano potuti sparire dai discorsi della sinistra e dalla sua percezione del mondo sociale, quando sono proprio le realtà più concrete delle esistenze individuali a essere in gioco, a partire dalla salute[12].
È una domanda che in molti si son fatti, guardando a cosa son stati gli anni Ottanta e Novanta e alle parole d’ordine diffuse a reti unificate dai media e tuttora filtrate nel linguaggio comune come verità eterne, indiscutibili (il darwinismo sociale, il mercato come sinonimo di democrazia, etc.): tanto diffuse, in verità, da aver fatto tabula rasa per più generazioni di un lessico politico capace di interpretare il nuovo contesto, di contrastare i fenomeni sempre più complessi e laceranti innescati dalla globalizzazione dell’economia e dalla precarizzazione del lavoro, con la conseguente ed esponenziale crescita delle diseguaglianze. La risposta di Eribon, al riguardo, è nel terzo capitolo del Ritorno, dove si tratteggia una «metamorfosi» della sinistra che non riguarda certamente la sola Francia e il solo Partito Socialista: si tratta di fenomeni di amplissima portata, su cui esiste ormai una folta bibliografia che la dice lunga sulle miserie del “progressismo” liberista. Inutile insistere; non è però inopportuno – data la tabula rasa di cui sopra – rammentare quanto scrive Eribon. Siamo nel 1981, Mitterand è all’Eliseo; allora la sinistra
cominciava a posizionarsi con un entusiasmo sospetto sotto l’influenza di intellettuali neoconservatori che, con la scusa di rinnovare il pensiero di sinistra, si adoperavano per cancellare tutto ciò che rendeva tale la sinistra. Si venne così a produrre una metamorfosi generale e profonda sia dell’ethos che dei punti di riferimento intellettuali. Non si parlò più di sfruttamento o di resistenza, ma di “modernizzazione necessaria” e di “rifondazione sociale”; non si parlò più di rapporti di classe, ma di “vivere insieme”; non si parlò più di destini sociali ma di “responsabilità individuale”. La nozione di dominazione e l’idea di una opposizione strutturante tra dominanti e dominati scomparvero dal paesaggio politico della sinistra ufficiale[13].
Bisognava, insomma, «disfarsi dell’idea che esistevano dei gruppi sociali – delle “classi” – e giustificare, così, la demolizione del welfare state e della protezione sociale, in nome di una necessaria individualizzazione (o decollettivizzazione, desocializzazione) del diritto del lavoro e dei sistemi di solidarietà e redistribuzione[14]». Operazione riuscita, lo sappiamo, che anche in Italia ha alimentato derive che dire reazionarie è davvero un «eufemismo», se han consentito alla destra più estrema di condizionare per così dire a vele spiegate le agende dei governi locali e nazionali (complici nell’applicazione del peggio, dalla sanità alla scuola ai servizi). Ma va anche notato, d’altra parte, che interpretare l’occultamento ideologico del conflitto e dell’antagonismo con la facile formula-etichetta dell’«individualismo di massa» significa, per Eribon, stare al gioco di chi ha cancellato ogni «frontiera» tra destra e sinistra; come osserva infatti in una breve nota
Il fatto stesso che per analizzare la “precarizzazione” del mondo del lavoro si sia potuto sviluppare il concetto tanto insulso quanto inadeguato di “individualismo di massa” la dice lunga. Questo concetto ci dà molte più informazioni sulla triste traiettoria che ha portato i sociologi che lo utilizzavano dalla sinistra critica ai cenacoli tra tecnocrati e al pensiero neoconservatore, che sulla realtà delle “metamorfosi della questione sociale”[15].
Si può annotare in margine a queste osservazioni, per allungare la visuale all’altra riva della Manica, che è del 1987 la celebre affermazione di Margareth Thatcher, ora disponibile anche in versione epigrafica per magneti da frigo: «There is no such thing as society. There are individual men and women, and there are families»: Non esiste una cosa come la società. Ci sono uomini e donne, e le famiglie[16]. Ebbene: è proprio riflettendo sul microcosmo familiare che Eribon ci parla della società, come per smentirne la pluridecennale rimozione dalla discussione sui destini di tutti.
Ritorno a Reims si conclude con questo scambio tra l’autore e la madre: «Quando annunciai a mia madre che mi avevano offerto un posto [all’università], mi chiese emozionata: “E di che diventi professore? Di filosofia?” – “Di sociologia, piuttosto.” – “Che cos’è? C’entra la società?[17]». L’affettuosa e silenziosa ironia della fine ci rimanda al percorso (doloroso, impietoso, e per questo necessario) che il lettore ha inseguito per le pagine del libro; ma a farla breve, se c’è una epigrafe che compendia la vicenda di Ritorno a Reims, è quella che a suo onore Eribon riprende da un vecchio maestro: «L’importante non è quel che si fa di noi, ma quel che facciamo noi stessi di ciò che hanno fatto di noi[18].»
2.
In un saggio del 1953 raccolto in Verifica dei poteri Franco Fortini ragionando su Tonio Kröger di Thomas Mann e su La svolta di Klaus Mann notava come sia possibile ricondurre il motivo del Ritorno e gli «innumerevoli nòstoi del nostro tempo[19]» a «una medesima radice psicologica, ad un eterno momento dell’anima»; ma aggiungeva questa avvertenza:
Se in questo vediamo solo un normale processo della coscienza, l’atto del ricordo e della verifica, l’assunzione della identità nella diversità, il dialogo delle generazioni, dove il figlio genera il proprio padre, è probabile ci sfugga il significato specifico e storico che questo processo ha assunto nel nostro tempo, e la ragione della sua vera importanza[20].
Al centro di quel saggio era una lettura dell’opera di Thomas Mann in relazione ai mutamenti della società tedesca ed europea tra Otto e Novecento; senza entrare nel merito delle analisi fortiniane, che in poche vertiginose pagine chiamano in causa Goethe e Tolstoj, Stendhal e Joyce, è tuttavia da non dimenticare, oggi come allora, il richiamo alla dimensione storica entro la quale il motivo del Ritorno trova – può trovare – la sua reale applicazione o esecuzione. Resta vero infatti che quel motivo diventa pregnante e moltiplicatore di significati laddove esso incrocia le trasformazioni che la società affronta, spesso se non sempre in modo drammatico, in determinati periodi: così non solo nell’archetipico Tonio Kröger, o in La svolta, ma anche nel Giardino dei ciliegi di Cechov o Babylon revisited di Francis Scott Fitzgerald o ancora, in tempi a noi più prossimi, The Homecoming di Harold Pinter[21]. Le ricognizioni dei Ritornanti assumono allora il senso di un confronto tra epoche che si succedono trascinando con sé i destini individuali e collettivi, mettendo di fronte e l’uno contro l’altro caratteri, storie vecchie e nuove, profili sociali – le «classi»… -, e percorsi differenti e conflittuali; lo scorrere del tempo si dilata e ispessisce come un fiume prima di una pescaia o di una cateratta per poi frammentarsi e precipitare in nuovo corso, o più corsi. È in questi momenti di «accelerazione» – per sfruttare un termine dell’indagine storica a cui Hartmut Rosa ha attribuito di recente un ruolo chiave nell’interpretazione della «tarda modernità[22]» – che le vicende individuali dei ritorni si caricano di senso, come avviene in Eribon nel passaggio degli anni Ottanta e nel confronto tra passato e presente.
In Ritorno a Trieste di Sergio Bologna c’è, come in Ritorno a Reims, la dimensione del ricordo, che prende qui le mosse dal ’45:
74 anni. Prendo spavento a pensare che c’ero, anzi, che me lo ricordo quel 1 maggio del 1945. E che i testimoni di quegli avvenimenti non sono rimasti tanti. Non dico in generale, dico quelli che hanno visto ciò che ho visto io, a Trieste, in una casa da dove si vedeva la sagoma del Castello, ultima roccaforte della resistenza tedesca all’avanzata dell’esercito di liberazione yugoslavo[23].
Questa l’apertura – una casa, una data, uno sguardo – della sezione intitolata Identità controverse, la penultima del libro: titolo esplicitamente saggistico, che annuncia il nucleo problematico della rivisitazione, dopo quasi sessant’anni di assenza, della città in cui l’autore è nato – e più in generale, si potrebbe dire, della stessa nozione di «identità» – e dove le mutazioni sono collegate alla funzione cruciale del porto, nelle sue varie fasi dalla seconda metà dell’Ottocento, quelle di slancio imprenditoriale innovativo e lungimirante a quelle di crisi, sino alla ripresa ai nostri giorni[24]. Non solo la cornice temporale di Ritorno a Trieste abbraccia dunque un periodo molto ampio, ma vi corrisponde un’apertura altrettanto significativa a livello culturale, il che avviene senza mai perdere l’ancoraggio al tema del lavoro e a quello dei relativi diritti, che tiene fermamente insieme il tutto[25]. L’occhio, infatti, non è qui di un osservatore neutrale o di un erudito, bensì dello storico del movimento operaio, ma anche dell’esperto di logistica[26], settore quant’altri mai essenziale nell’economia globalizzata di oggi. Tale apertura o meglio costante militanza – sia detto subito per allontanare qualsiasi ombra accademica dal libro – è un fattore importante in ordine al messaggio complessivo di Ritorno a Trieste, ovvero al modo del tutto originale di leggere la società che vi ha luogo attraverso i vari saggi, tanto densi quanto articolati. Non c’è pagina in cui non senti il riflesso di un’esperienza diretta, gli schemi prefabbricati e le falsificazioni ideologiche saltano per aria ad ogni capitolo: come auspicava Walter Benjamin, la storia viene rispazzolata contropelo. Così è per il Sessantotto[27], così per le vicende di Trieste o per il passaggio dal Fordismo al Posfordismo e per il discorso sul lavoro, dalla svolta dell’ottobre 1980 all’epoca dei riders e degli hackers. E si noti bene, se il libro si apre sulla domanda Che cos’è il lavoro?, si chiude poi su un altro interrogativo: La fine del lavoro come fine della storia? In questa modalità interrogativa non c’è traccia di retorica: si tratta di un pensiero critico e libero che scava in presa diretta nelle contraddizioni della società contemporanea; e di questo abbiamo un disperato bisogno, se veramente (e non per slogan o per delega) vogliamo ritentare un lessico e riformulare una politica efficace per le lotte contro l’ingiustizia di oggi – e di domani: Questioni del domani s’intitola, non per caso, la sezione finale di Ritorno a Trieste. Certo: «Ma che fatica doversi sbarazzare di idiozie, luoghi comuni, elucubrazioni accademiche, discussioni inutili, falsi problemi… prima di raggiungere finalmente il punto di partenza![28]»
Esemplarmente, nell’ultima pagina il libro consegna al lettore una serie di proposte (non profezie o teorie da piazzare in un Master con il solito PowerPoint) volte a rianimare e consolidare la pratica del conflitto in seno alle nuove realtà lavorative, così recuperando spazi di negoziato nell’ambito di ciò che Bologna chiama, esattamente, la «modernizzazione regressiva[29]» (un poeta come Andrea Zanzotto parlava di «progresso scorsoio»…) dei nostri anni. Analogamente, la prima delle Tre lezioni si concludeva con Dieci consigli per cavarsela bene, un memo prezioso perché pragmatico e antidogmatico che i giovani dovrebbero tener sempre nello zaino. La lezione dell’autore, inseparabile da uno stile intellettuale che va dritto al cuore delle questioni, passa attraverso questo doppio movimento: un andirivieni tra il passato e il futuro consapevole che ogni conquista è precaria se il conflitto non viene rilanciato ad ogni nuova sfida nei riassetti della società, per sua natura e per volere degli uomini in perenne evoluzione. Lo spunto di partenza non è il passato, ma il presente; e il presente appunto in quanto terreno di dialogo e di scontro. Anche l’autobiografia, pertanto, in Bologna si configura come pensiero vissuto e interrogante, nient’affatto come cronaca o album di memoria. Ritornare è per ricominciare, insomma, anzi è già un ricominciamento: il contrario che irrigidire il ricordo in reliquia. Ed è la risposta più giusta a chi intende congelare la Storia in un “così è” strumentale ad esorcizzare il possibile cambiamento; è per rimettere in moto le speranze e i progetti irrealizzati o traditi, invece, che lo sguardo torna al paesaggio di un tempo, ai luoghi degli antenati e a quelli delle nostre esistenze. Ancora una volta, per fare delle domande:
La nostra casa stava ai margini estremi del quartiere di San Giacomo, il quartiere degli operai dei cantieri, il quartiere “rosso” per eccellenza. Per prendere il Castello i partigiani dovevano passarci davanti. A due passi dalla nostra abitazione – si sarebbe saputo dopo – c’era la sede clandestina del “Primorski Dnevnik[30]”. Ma la mia non era una famiglia “rossa”, era mezza nera e mezza tricolore. Mio padre era fascista, perché lo fosse diventato fa parte di quegli enigmi che spiegano il disorientamento di un popolo, lui che era stato massone, chissà perché, lui dal quale ho imparato il rispetto e l’amore per il lavoro, il rispetto per la donna – lui che non ha mai alzato le mani su di me, che non mi ha mai impedito di fare qualunque cosa, lui che ha lavorato tutta la vita nei cantieri navali come tecnico progettista senza chiedere aumenti di stipendio perché non gli pareva dignitoso. Quest’uomo buono e mite, dal carattere introverso, tenace e ostinato come i liguri sanno essere, di un’onestà maniacale, che da ragazzo aveva patito letteralmente la fame, era irrimediabilmente fascista. Perché?[31]
Immagine di copertina: Olga Pringsheim, Klaus Mann, 1926
Note:
[1] Didier Eribon, Ritorno a Reims, Milano, Bompiani, 2017.
[2] In Italia Corpo di classe: Ritorno a Reims ovvero Didier Eribon secondo Thomas Ostermeier è stato messo in scena al Piccolo Teatro Melato con Sonia Bergamasco, Rosario Lisma e Tommy Kuti nel novembre 2021; vedi la recensione di Giulia Alonzo https://www.doppiozero.com/materiali/eribon-tra-gender-e-avanzate-delle-destre. Il film è di Jean-Gabriel Périot: Retour à Reims, presentato alla “Quinzaine des Réalisateurs” a Cannes; vedi sul canale Arte Retour à Reims [Fragments] – Regarder le documentaire complet | ARTE ; per una di storia della ricezione in Francia (e non solo) del libro cfr. Comment “Retour à Reims” est devenu un best-seller sociologique (franceculture.fr). Ringrazio Andrea Inglese per le segnalazioni.
[3] D. Eribon, Michel Foucault. Il filosofo del secolo. Una biografia, Milano, Feltrinelli, 2021.
[4] Quanto alle recensioni, nelle grigie pagine culturali italiane le poche che se ne sono lette han dato la netta impressione che gli autori non si siano spinti molto oltre la confezione, per l’appunto, salvo intonare qualche banalizzante e inflazionato lamento sulla “deindustrializzazione”.
[5] D. Eribon, Ritorno a Reims cit., p. 46.
[6] Ivi, p. 196.
[7] Ibidem.
[8] Ivi, p. 38. Il riferimento è alla voce “Gauche” di Gilles Deleuze, L’Abécedaire de Gilles Deleuze, DVD, Èditions de Montparnasse, 2004 (ed. it. DeriveApprodi 2014).
[9] Ivi, p. 27: James Baldwin, Notes of a Native Son, London – New York, Penguins, 1995 (trad. it. Appunti americani, Firenze, Le Lettere, 2007).
[10] Ivi, p. 213: Raymond Williams, Border Country, Cardigan, Parthian 2006 (I ed. 1960, Horizon Press); trad. it. di C. Mezzacappa Terra di confine, Vedano al Lambro, Paginauno, 2018.
[11] Ivi, p. 74.
[12] Ibidem.
[13] Ivi, p. 210.
[14] Ivi, pp. 110-111.
[15] Ivi, p. 111.
[16] Si ricordino le annotazioni di Elias Canetti in Party sotto le bombe (Milano, Adeplhi, 2005, p. 194) : «In brevissimo tempo la nuova parola d’ordine fu: Io per me, e gli altri vadano al diavolo. Si scoprì allora – e con stupore, devo ammetterlo – che l’egoismo, non meno dell’altruismo, si presta a diventare oggetto di predica. Al ruolo di sommo apostolo nel Paese assurse una donna, la quale opponeva regolarmente il proprio rifiuto a qualsiasi iniziativa destinata agli altri; per gli altri tutto era troppo dispendioso, per se stessa nulla lo era abbastanza. Acqua, aria, luce vennero messe nelle mani degli uomini d’affari – e lì, a seconda dei casi, prosperarono o fallirono. Il più delle volte fallirono. […] Grazie a lei molte città andarono in malora. La qualità delle scuole decadde affinché i ragazzi imparassero per tempo a contare solo su se stessi e diventassero spietati.»
[17] Ivi, p. 215.
[18] Ivi, p. 196. La citazione è da Jean-Paul Sartre, Santo Genet, commediante e martire, Milano, Il saggiatore, 1972, p. 55.
[19] Franco Fortini, Due ritorni, in Verifica dei poteri. Scritti di critica e di istituzioni letterarie, Milano, Il Saggiatore, 19651 (n. ed. ivi, 2017), p. 307.
[20] Ibidem.
[21] Per un excursus in chiave letteraria rinvio al mio Cronotopi novecenteschi. Intrecci di Spazio e Tempo in poesia, Macerata, Quodlibet, 2020.
[22] Hartmut Rosa, Accelerazione e alienazione. Per una teoria critica del tempo nella tarda modernità, Torino, Einaudi, 2015.
[23] Sergio Bologna, Ritorno a Trieste. Scritti over 80, 2017-2019, Trieste, Asterios Editore, 2019, p. 209.
[24] Vedi in particolare nella sezione Identità controverse il saggio Un passato che ritorna. Pensieri disordinati su grandezza e miseria di una città nordadriatica, pp. 217-279.
[25] Vedi specialmente le Tre lezioni, pp. 13-55.
[26] In quest’ambito si veda la sezione Logistica e infrastrutture, pp. 131-206.
[27] Di particolare rilievo nella sezione Storia e memoria i capitoli La vera rivoluzione del ’68, La memoria falsificata dell’autunno caldo e Il “lungo autunno”. Le lotte operaie in Italia negli anni ’70, pp. 59-127. Si ricordi che Bologna insieme a Giairo Daghini è autore del più bel reportage in diretta sul Maggio francese: Maggio ’68 in Francia, Roma, DeriveApprodi, 2008 (apparso in origine nel 1968 su «quaderni piacentini», VII, 35).
[28] Ivi, p. 296.
[29] Ivi, p. 291.
[30] «Quotidiano del Litorale»: giornale pubblicato a Trieste in lingua della minoranza slovena del Friuli-Venezia Giulia.
[31] Ivi, p.p. 210-211.