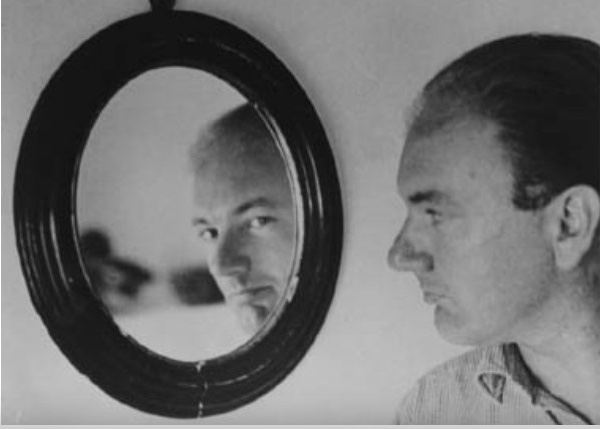
Dal kitsch alla barbarie
di Antonio Tricomi
Vien quasi voglia di considerare Antichi Maestri – la Commedia, come ci informa il sottotitolo, licenziata da Thomas Bernhard nel 1985 e da poco riproposta in traduzione italiana – una sorta di prosecuzione del discorso affidato da Hermann Broch a un saggio, Hofmannsthal e il suo tempo, concepito tra il 1947 e il 1948 e apparso, in una prima edizione incompleta, nel 1949. Il bersaglio polemico di entrambi i libri è infatti il kitsch, nella cui egemonia sia l’uno sia l’altro autore riconoscono qualcosa di più che la semplice spia del degrado culturale patito dalla peculiare epoca storica nella quale, a ciascuno di essi, toccò in sorte di vivere. Per Bernhard come per Broch, la vieppiù crescente, e infine assoluta, legittimazione pubblica del cattivo gusto costituisce, invece, il destino pressoché obbligato di quella trionfante modernità borghese di cui perciò anche attesta l’intrinseca insania etica, inevitabilmente incline a generare, nella società, inarrestabili processi di corruzione etico-politica. Il kitsch, insomma, quale sintomo di una malattia incurabile, perché, almeno da un certo momento in poi, capace addirittura di tradursi nell’immutabile profilo identitario di una civiltà occidentale da essa dunque condannata, presto o tardi, alla catastrofe.
Ebbene, Broch non ha dubbi: il «tanto razionale Ottocento» iniziò presto «a dare ovunque segni di irrazionalità, e non da ultimo nella sua esaltazione per le macchine e la produttività». Fagocitato, sempre più, dal proprio «radicalismo», che lo spingeva a sviluppare «al massimo, fino all’estrema astrattezza», la sua ossessione scientista ma anche a non poterla mai appagare, esso giunse insomma a celebrare il mito di un’integrale, estetizzante rivoluzione culturale che però anzitutto scaturì dal traumatico affievolirsi della «religiosità cui era improntata la vecchia Europa» e dal «frazionamento dell’onnicomprensivo sistema religioso di valori in singoli sistemi autonomi», sicché decadde «la validità universale dei comportamenti etici fino allora in vigore» e «presero a scatenarsi gli istinti fino allora tenuti a freno da ragioni etiche». Ne derivò un «vuoto di valori» che toccò principalmente a un’arte ridotta, pur in pompa magna, a inflazionato addobbo sociale e affettato fregio culturale, non soltanto rispecchiare, ma sforzarsi, finanche, di occultare. Di qui, secondo Broch, il trionfo di quel «genio del vuoto» che fu, a parer suo, Wagner o la disponibilità, per lo scrittore palesata da Vienna più che da ogni altra città europea, a scambiare «la musealità con la cultura», sì da adempiere il proprio «dovere di fedeltà alla tradizione». Perché, arguiamo da Hofmannsthal e il suo tempo, il kitsch è appunto questo: il patetico, regressivo «vegetare» di una società in una «ricchezza» però trascorsa, e dunque un inequivocabile «segno» di «decadenza» civile (pp. 38, 51, 62-63, 56, 68).
Non per nulla, prosegue Broch, il Novecento poté poi dimostrarsi «il secolo della più fosca anarchia, dell’atavismo più fosco, della più fosca crudeltà». Per l’autore dei Sonnambuli, il XIX secolo durò infatti non «dal capodanno del 1800 a quello del 1900», ma «dal 1848 fino alla prima guerra mondiale». In questo intervallo di tempo, «il pensiero politico», stritolato dall’assenza di valori di cui si è detto, risultò «del tutto assente, o perché non ancora sviluppato o perché già inaridito», mentre «la categoria estetica» acquisì, per l’appunto, «sempre maggior risalto», causando, in ciascun ambito sociale, «una tendenza vieppiù marcata all’ornamentazione e alla decorazione della vita», sì da «suscitare quell’indifferenza etica che – contraltare dell’iconoclastia – si manifesta come puro edonismo, come pura smania di godimento». Per cui, a favorire anche le successive, immani catastrofi del Novecento, ha provveduto, secondo Broch, proprio l’apoteosi, nel frattempo divenuta culturalmente incontrastabile, del kitsch, fisiologico esito pubblico di un’urgenza, anche psicologica, nutrita dagli individui tutti: quella di celare «un minimo di valori etici» con «un massimo di valori estetici, che però non erano e non potevano più essere tali, giacché un valore estetico privo di una base etica è l’esatto contrario di se stesso» (pp. 39, 185, 102, 109-110).
Se l’Ottocento si rivelò quindi «l’età del kitsch per eccellenza», nutrendosi, con particolare appetito, «dell’estetizzazione borghese e dell’eclettismo a essa connesso», pensò poi il secolo seguente a realizzare il programma da esso annunciato: la «disumanizzazione del mondo». Traguardo che s’incaricò la politica – frattanto divenuta «in tutta Europa sempre più difficile da tenere a freno» – di raggiungere. In principio, assumendo «i tratti della follia, senza naturalmente essere davvero folle». In ultimo, se fu proprio dal vizio dell’«estetismo» che scaturirono le retoriche del «superomismo», giungendo a risolversi in «un’escatologia sacrilega», animata «da un misticismo estetizzante», e a reiterare ancestrali esaltazioni della supposta forza purificatrice della guerra. Perché, si evince da Hofmannsthal e il suo tempo, già all’alba del Novecento la vera colpa, in special modo del popolo tedesco, fu quella di rinnegare ogni scrupolo attinente la sfera dell’etica per ridurre quest’ultima a posticcio manto – subito riconvertito, peraltro, in opportunistica giustificazione dei più belluini istinti individuali e collettivi – di una crescente smania di normalizzazione politica e rivalsa culturale infine placata solo dalla costruzione della totalitaria società nazista, a propria volta degradata dal Führer, e dai sudditi di costui, a enfatico, ferale ornamento dell’irrefrenabile ossessione omicida, e suicida, che mosse un’intera nazione (pp. 241, 245-247).
Non è dunque un caso che Antichi Maestri sia ambientato nel Kunsthistorisches Museum di Vienna. Come al solito, Bernhard lavora da ventriloquo, rifrangendo la sua inconfondibile voce ossessivamente tragica nei monologhi, nei dialoghi, nei soliloqui di maschere incaricate di offrirci una disperata, luciferina partitura satirica. Egli vuol dirci, questa volta, che «il mondo intero», nella seconda metà del Novecento, è via via divenuto «un mondo ridicolo, profondamente penoso e kitsch». E che anzi «pedanteria e kitsch» hanno finito col rivelarsi «le qualità fondamentali dell’uomo cosiddetto civilizzato», a tal punto smanioso di dimostrarsi «stilizzato nel corso dei secoli e dei millenni», da essersi in ultimo degradato a «una figura grottesca», pronta a tradurre in un’epifania del cattivo gusto qualunque cosa egli tocchi, anche «la grande arte e l’arte grandissima». Da lui vieppiù ridotte a campionari di forme tutte indistintamente celebrate e quindi fruibili, da masse di acritici consumatori in cerca di facili emozioni pseudoculturali, solo perché preventivamente museificate, cioè esposte o riprodotte in serie dopo aver provveduto ad azzerarne ogni originario significato (pp. 81, 120).
In quest’ottica, un qualunque museo, per Bernhard, altro allora non è che il luogo in cui plasticamente si svelano il meccanismo di funzionamento e l’onnipervasivo dominio dell’industria culturale. Che, da un lato, rende «di gran moda», in ogni campo, «il sentimentalismo e il kitsch», ossia trasforma il rapporto con l’arte e col sapere in una «prerogativa» tipica «degli idioti»: nell’estrinseca «ammirazione» per un bello non soltanto astratto, ma anche assimilato alla sua sistematica «contraffazione», e per un vero identificato con una risibile «caricatura» di qualsivoglia autentica intenzione conoscitiva. E che, dall’altra parte, deve la sua inscalfibile egemonia proprio alla capacità di imporre su scala planetaria «la menzogna», giocando con «la fame di cultura nell’umanità civilizzata» per produrre non già le condizioni che permettano di saziarla, ma una società in tutto simile alla Vienna di fine Novecento quale lo scrittore la ritrae: uno spazio, sia fisico sia mentale, che «tanto più tenacemente» rappresenti una mera «idea della cultura», quanto più la cultura si dimostri esangue e, anzi, «scomparsa». Riconvertita, cioè, in un puro strumento di potere: in «arte cattolica di Stato» o in quei falsi saperi impartiti «a bambini di Stato» da «atroci» insegnanti disposti a lavorare come «funzionari di Stato» in «scuole di Stato» esclusivamente preoccupate di produrre «esseri umani di Stato» (pp. 56, 75-78, 147, 113, 37-41).
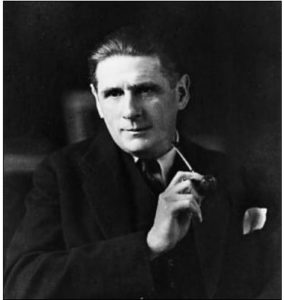
[un’immagine di Hermann Broch]
Bernhard ne è infatti certo. In un mondo in cui tutto è «degenerato ai livelli più infimi di ottusità», dal pensiero non possono appunto che scaturire «malvagità e menzogna e ipocrisia». Il che spiega, agli occhi dello scrittore, sia il culto, in un’epoca simile, di un intellettuale come Heidegger (che egli reputa un autore «soltanto comico», un «ciarlatano» propenso a «ridurre senza alcun riguardo le grandi idee altrui alle proprie piccole idee», facendo indossare «alla filosofia tedesca il suo nero berretto da notte kitsch»), sia il costante svilimento, in siffatta società subdolamente autoritaria (e dunque oltre misura «brutale e ignobile e votata all’autodistruzione»), del «singolo individuo», di fatto equiparato a un’asettica particola di un impersonale esercito di automi. Così come chiarisce perché gli uomini si giudichino infine delusi da un’arte di cui essi ritengono di non poter più produrre o passare compulsivamente in rassegna nuovi esiti creduti «autentici», e della quale si sentono allora obbligati a fruire con autistica e tuttavia distratta sistematicità, o persino a studiare «minuziosamente» eppure senza reale interesse, le antiche forme (pp. 128-130, 58-60, 160, 85, 100, 138).
Un capolavoro – nota del resto Bernhard, che così ci offre un implicito manifesto della propria poetica modernista – non è mai un’opera aridamente perfetta, ma «un tutto, una cosa finita, compiuta», che a tale esattezza semplicemente mira e che però si rivela in grado di parlarci solo se esibisce un «errore palese» che, da noi riconosciuto, ci permetta di convertire siffatta pretesa di totalità espressiva in «un frammento» di verità sia formale, sia enunciativa. Perché, aggiunge lo scrittore, solo «il fallimento dell’artista», e della sua ambizione a costruire un autosufficiente congegno estetico, può sollecitarci a rendere la nostra «mente» un’effettiva «mente umana», illuministicamente pronta a mettersi «alla ricerca degli errori dell’umanità» sì da emendarli o, quantomeno, da non ripeterli. L’aver quindi equiparato gli «Antichi Maestri» dell’arte e del pensiero ad autori di capolavori invece intesi quali inalienabili concrezioni di perfezione assoluta, ci vieta, viceversa, sia di intenderne davvero, sia di sfruttarne per un qualche nostro reale profitto esistenziale la lezione. In altri termini, rende «vuota» la «cassaforte dello spirito» di cui ci credevamo padroni grazie a loro, suggerendoci che, per adempiere «i nostri fini», ossia per assecondare il nostro precipuo desiderio di «sopravvivere», a nulla valgono le «migliaia e migliaia di libri e di scritti» che già abbiamo vagliato e che ancora potremmo compulsare (pp. 29-31, 174-175).
Il che determina, chiosa Bernhard, un profondo, radicato disprezzo collettivo per quello stesso sapere febbrilmente ridotto, in nome di una convenzionalmente incontestabile «impostura democratica», a merce in perenne compravendita. Perché, precisa lo scrittore, un secolo, il xx, che pur l’ha resa, con le due guerre mondiali, apocalittica realtà sociale, si conclude dissimulando «la tragedia» in una «commedia» repellente, che legittima ciascun interprete a ritenere che non ci sia «più niente di straordinario», e quindi a svalutare tutto ciò che ecceda o umili le sue ridotte, intrinsecamente risentite capacità piccolo-borghesi di comprensione. Una commedia costantemente alimentata da quel «populismo ipocrita», e anzi «disgustoso», di cui si fanno ossessivamente «garanti», leggiamo in Antichi Maestri, «politici» in grado di ricavarne un’inesausta dottrina di normalizzazione sociale. Non prima, però, di aver reso ogni essere umano «totalmente abbandonato a se stesso e totalmente indifeso», sicché privo di «un buco dove potersi rifugiare, a meno di trovare riparo nella morte» (pp. 186-187, 169, 181).
Quasi trentacinque anni ci separano dalla pubblicazione del libro di Bernhard, impeccabile nel ritrarre gli ultimi fuochi d’artificio, e dunque il massimo sforzo di edonistica autocelebrazione socioculturale, di quell’era borghese, investigata tanto da Hofmannsthal e il suo tempo quanto da Antichi Maestri, che l’odierno sprofondamento in un nuovo medioevo parrebbe ormai dichiarare al tramonto. Perché, lungo quell’intera stagione, nella progressiva riduzione della cultura a massificato, totalitario ornamento piccolo-borghese, al sapere finiva ancora con l’essere attribuito un pur paradossale, posticcio, reazionario valore sociale: era infatti richiamandosi a forme di esso vieppiù alienate, è indubbio, e tuttavia a sue degradate e degradanti occorrenze pubbliche, che le comunità e gli individui ambivano a nobilitare le proprie fisionomie.
Viceversa, l’impressione è che oggi, in una società neo-feudale, composta da pochi, garantiti signori e da schiere di loro subalterni abbandonati, in quote diverse, a un asfittico, frustrante impoverimento, si conceda, ai primi, di proseguire sulla vecchia strada dell’autoreferenziale museificazione della cultura, e poi si offrano, ai secondi, retoriche identitarie esplicitamente fondate sull’abiura di qualunque aspirazione conoscitiva, sul rigetto di ogni canonico sapere formalizzato e, insomma, su logiche che autorizzano una riscoperta collettiva della barbarie. Tanto che ormai la stessa industria culturale si rivela sempre più incline a largire al pubblico non soltanto occasioni di decorativo, banalizzato sapere, concepite per consumatori che pretendano, cogliendole, di acquisire e di ostentare una maggiore credibilità civile, ma, in gran parte, prodotti scopertamente triviali, che sdoganino le aspirazioni dei fruitori a veder socialmente giustificato il proprio disincanto nei riguardi dei tradizionali modelli conoscitivi, apertamente dileggiati. E se anche a proposito della filiera educativa (scuola, università) si può forse sostenere qualcosa di simile, che dire degli attuali populismi vieppiù egemoni in Occidente, da quelli solo qualunquistici a quelli che si proclamano sovranisti? Essi conquistano consensi eccitando, sì da gratificarli e renderli politicamente degni, l’incolto rancore, l’avventuriero pressappochismo, le paranoiche superstizioni, il tribale oscurantismo, l’analfabeta fideismo xenofobo, l’inciviltà di masse entusiasticamente inselvatichitesi.
Bibliografia:
Thomas Bernhard, Antichi Mastri. Commedia, Adelphi, Milano, 2019.
Hermann Broch, Hofmannsthal e il suo tempo, Adelphi, Milano, 2010.
[in copertina un’immagine di Thomas Bernhard]